Troppo grande, Alfredo! Devi trovare il mo di farla arrivare veramente ai destinatari questa "supplica" che non può che essere…
Taula a San Ciseppe
- Home
- Taula a San Ciseppe

Taula a San Ciseppe
di Ornella Ricchiuto – –
Immaginate di entrare in un grande salone luminoso dove un folto gruppo di sole donne siede davanti a una lunga tavolata a ferro di cavallo. La più giovane ha 27 anni mentre la più anziana 88. Donne giovani, adulte e anziane danzano in una coreografia in cui le mani si muovono a ritmi diversi, a seconda dell’esperienza, ma con la stessa visione culinaria da raggiungere: i vermiceddhi per la Tavola di San Giuseppe.
“Aje facimu vermiceddhi de settant’anni, jeu ca ne tegnu ottanta”…
“A comare Lina nc’è cquai? Iddha è a rota, iddha gira sempre”…
“Ne sta nsurtamu una l’autra”…
“Me ne dai menza tua ca a scanu?”
“La zia mia ha fatto la tavola de muti anni e jeu infatti era a Madonna (…) Jeu su nata a giugnu e la Madonna l’aggiu fatta a marsu, quindi nu tinía mancu n’annu e l’aggiu fatta fino a trent’anni.” Tannu era tuttu cucinatu.”…
“Io l’ho fatta cucinata tutta per tre anni (…) perché San Giuseppe u fastidiu vole poi.”…
“San Giuseppe meu beddu”…
“Hai vistu comu simu brave?”…
“Farina uliti? Nà!”…
“Allora se facíune i voti una volta per San Giuseppe”…
“Le donne devono fare tutto”
“San Ciseppe lu vecchiarellu,
era sposu de Maria,
in brazze purtava lu Ninni bellu,
lu cantava e lu durmiscia.
E io dissi: «Vecchiarellu,
veni e curcate a casa mia,
t’aggiu cunzatu le lettu bellu,
de stu core dell’anima mia».”
Memorie, preghiere, racconti, battute di spirito si intrecciano in un devoto silenzio frastornante avvolgendo qualunque passante in un’energia dirompente e sacra, fatta di nomi come Lina, Maria, Tetta, Ada, Renata, Pierina, Domenica, Rosina, Serena… e di saperi ereditati dalle generazioni passate.
È il 17 febbraio 2025 e davanti ai miei occhi curiosi vi sono le donne di Cocumola dove ancora oggi, come scriveva il poeta Bodini, “la vita cocumola fra le pentole”, donne che preparano i fritti, impastano i vermiceddhi, gli spaghetti cu llu mele e altre pietanze per la tavola di San Giuseppe.
Le tavole di San Giuseppe hanno un posto d’onore tra le feste del calendario religioso nell’Italia meridionale e insulare (Puglia, Basilicata e Sicilia), segnano il ritmo delle stagioni in contiguità con l’equinozio di primavera e seguono il calendario agricolo (finocchi, carciofi, rape, arance, asparagi, cavoli,…). Questa ritualità conservava (conserva?) una polisemia di significati chiaramente in connessione con quanto richiedeva San Giuseppe: la condivisione di cibo, l’accoglienza, la carità verso i poveri, l’offerta della propria fatica agli altri.
Per quanto riguarda la simbologia dei cibi, si prevede un numero dispari di pietanze, dalle tre della Sacra Famiglia – San Giuseppe, la Madonna e Gesù Bambino – alle tredici che comprendono di solito, oltre alle tre precedenti, anche Sant’Anna e San Gioacchino (genitori di Maria), Santa Veronica (discepola di Gesù), San Lazzaro e Santa Marta (gli amici più stretti), Sant’Elisabetta (cugina di Maria) e il marito San Zaccaria, San Giovanni Battista (figlio di Sant’Elisabetta e San Zaccaria), Santa Maria di Cleofa (sorella di Maria) e altri Santi a cui la famiglia è particolarmente devota.
Anche i cibi hanno peculiari simboli, ne cito alcuni:
- i lampascioni conditi con olio e aceto designano la fine dell’inverno e l’inizio della primavera
- il colore bianco e giallo della massa e ceci rappresenta il narciso, fiore tipico dei primi tepori della primavera
- la pasta con miele e mollica di pane è frutto dell’obbligo di astinenza quaresimale
- la verdura bollita condita con olio (mugnuli e cavolfiore) ricorda il bastone fiorito di San Giuseppe
- l’olio rappresenta l’alimento divino sin dai tempi di Omero; nell’antico testamento l’olio era simbolo di prosperità, di benedizione divina, di gioia, di fraternità
- il vino è l’amore verso Dio, rappresenta il sangue di Cristo sparso sulla terra per redimere l’umanità dal peccato
- il finocchio, ortaggio di colore bianco, viene considerato simbolo di purezza, di candore dell’infanzia di Gesù bambino
- l’arancia raffigura la fertilità
- il pane, preparato nei forni del paese, viene portato in casa e tenuto coperto, per la conservazione, con delle lenzuola. I pani, che identificano i santi, sono tutti di grandi dimensioni e hanno la forma di una ciambella. Sul pane sono riportati in rilievo simboli religiosi: il bastone (San Giuseppe), la corona (la Madonna), i pani piccoli (Gesù Bambino). Al centro della ciambella viene collocata un’arancia. (Informazioni tratte da una scheda dell’ICCD del Ministero della Cultura redatta da Eugenio Imbriani, docente di Antropologia Culturale dell’Università del Salento).
La predisposizione di questi alimenti è accompagnata da tappeti, tende e tovaglie ricamate che rievocano l’immagine dell’altare sul quale troneggia una statua o un quadro del Santo che, a sua volta, richiama l’immagine dei sepolcri o delle veglie funebri.
A partire dalla seconda metà dell’800 le famiglie devote (chi aveva ricevuto una grazia dal Santo oppure per un’apparizione del Santo in sogno) allestivano nelle proprie case tavolate di piatti di cibi cotti, soprattutto poveri: legumi, verdure, pani votivi.
“Mi sognai San Giuseppe con tre pani / tondi / cinque pani / però sti cinque pani / belli
grossi/ […] così alla buona / ah / ma ce voi san Giuseppe da mia / gli dissi / san
Giusepe meu / senti / mo nun me sento tanta / bbona / ma ci vole Ddiu me sento bbona / da n’anno all’autro / fazzo la taula / […] erano tre persone / ca portavano cincu pani / andai al forno e feci fare sti cincu pani / […] in gloria di san Giuseppe / poi è venuto l’anno prossimo / aggiu ditto a maritema aggia fari a taula.” (Testimonianza di un’informatrice anziana in “Tavole di S. Giuseppe in Terra d’Otranto”, Vincenzo Esposito)
Nel corso del tempo le tradizioni mutano e si trasformano, e con loro si aggiornano e si arricchiscono le ricette e le composizioni dei piatti seguendo le evoluzioni di un gusto che non è soltanto alimentare.
In linea con le direttive della Convenzione di Faro del Consiglio d’Europa (2005), le tavole di San Giuseppe si inseriscono nelle comunità del Mezzogiorno d’Italia rendendo le Comunità stesse protagoniste attive e partecipanti nella loro riscoperta, salvaguardia, valorizzazione e trasmissione. Partendo dal presupposto che cibo è cultura, i soggetti che preparano, raccontano e visitano le tavole si costituiscono come “comunità di eredità” fungendo da collante tra le generazioni. Inoltre, nelle tavole di San Giuseppe ritroviamo alimenti – olio d’oliva, cereali, frutta e verdura fresca o secca, una quantità moderata di pesce, vino – che appartengono alla Dieta Mediterranea che nel 2010 è entrata nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell’UNESCO, riconoscendo le pratiche tradizionali, le conoscenze e le abilità che sono passate di generazione in generazione in molti paesi mediterranei fornendo alle comunità un senso di appartenenza e di continuità.
- Share
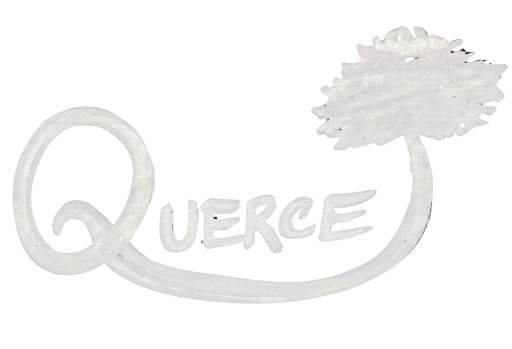


Una rappresentazione popolare familiare antichissima che vive una straordinaria attualità nella ricerca culinaria paesana del nostro tempo. Le mani delle donne sono le protagoniste attive semplici quotidianamente operose per la predisposizione del pasto familiare che oggi per noi assume significati di ricerca storica per la continuazione futura di tradizioni culinarie antichissime.