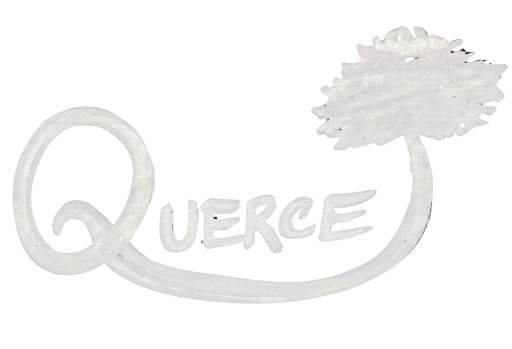Troppo grande, Alfredo! Devi trovare il mo di farla arrivare veramente ai destinatari questa "supplica" che non può che essere…
Lu Santu Lazzaru
- Home
- Lu Santu Lazzaru

Lu Santu Lazzaru
di Ornella Ricchiuto – –
“Santu Lazzaru mia pietusu
nna pezza de casu e nnu pilusu
nna pezza de casu e nnu pilusu.
Mena mena nnu fare mosse
Va pigghia l’oe queddhe chiú grosse
Va pigghia l’oe queddhe chiú grosse”.
Qual è l’origine dei riti e del canto de “Lu Santu Lazzaru” e come si è evoluto nel corso del tempo?
“Lu santu Lazzaru” si pratica ancora oggi in numerosi paesi del sud Salento. Si basa soprattutto su un canto di questua del periodo pasquale che ha origine da un contesto prettamente contadino. Fino alla metà del secolo scorso gruppi di persone – chiamate in gergo “squadre” – andavano in giro per le strade del paese ad annunciare la passione di Cristo e chiedendo in dono agli abitanti uova, formaggio e altri prodotti della terra. Quando i parenti o gli amici li facevano entrare in casa, gli esecutori spesso si inventavano nuove strofe rispetto ai soggetti presenti e fungevano altresì da richiamo d’amore verso una donna, si pensi ad esempio ai seguenti versi:
“E tu Rosaria ca sì chiú bella
va pigghia l’oe di la spurtella”.
Il canto viene eseguito da due cantori che si alternano nelle strofe su accompagnamento di tamburello, sonagliera e fisarmonica. L’offerta che segue alla richiesta dei questuanti concretizza uno scambio tra beni immateriali – l’auspicio di benessere, salute e prosperità – e beni materiali – alimenti. I questuanti rappresentano agenti del sacro e pertanto offrire loro qualcosa rappresenta un investimento utile ai fini dell’ottenimento futuro di un qualche beneficio. Le offerte si configurano come un dono da rivolgere alle entità trascendenti (Dio, la Madonna, i Santi, i morti) che propiziano il benessere delle persone e, quindi, i cicli della vita individuale e collettiva (in passato anche l’equilibrio e la corretta scansione dei cicli stagionali, l’abbondanza dei raccolti).
La questua di alimenti e il banchetto collettivo a Pasquetta sono ancora oggi fra le azioni rituali più evidenti delle feste campestri in Salento. Non dimentichiamoci che la pratica di rituali, come quelli festivi, ha la funzione di creare e/o rinnovare le relazioni sociali, si ribadisce l’appartenenza alla comunità e al culto comunitario.
Oggi sono in atto sia i processi di patrimonializzazione che vedono il coinvolgimento di giovani nell’esecuzione dei canti, sia i processi di spettacolarizzazione con la presenza di numerose manifestazioni e concerti in vari paesi.
Quali saranno le direzioni future di questo rituale attenzionato dalle politiche culturali tra ambienti domestici e palcoscenici? Riusciranno a veicolare i significati originari, a valorizzare le storie degli ultimi cantori e testimoni depositari del rituale prima del propagarsi della mercificazione della cultura, nonché dar voce ai nuovi protagonisti? Incrementeranno la realizzazione di studi e ricerche finalizzati a riflettere, analizzare e tramandare questo patrimonio culturale immateriale nei suoi aspetti più umani, sociali, educativi e comunitari?
- Share